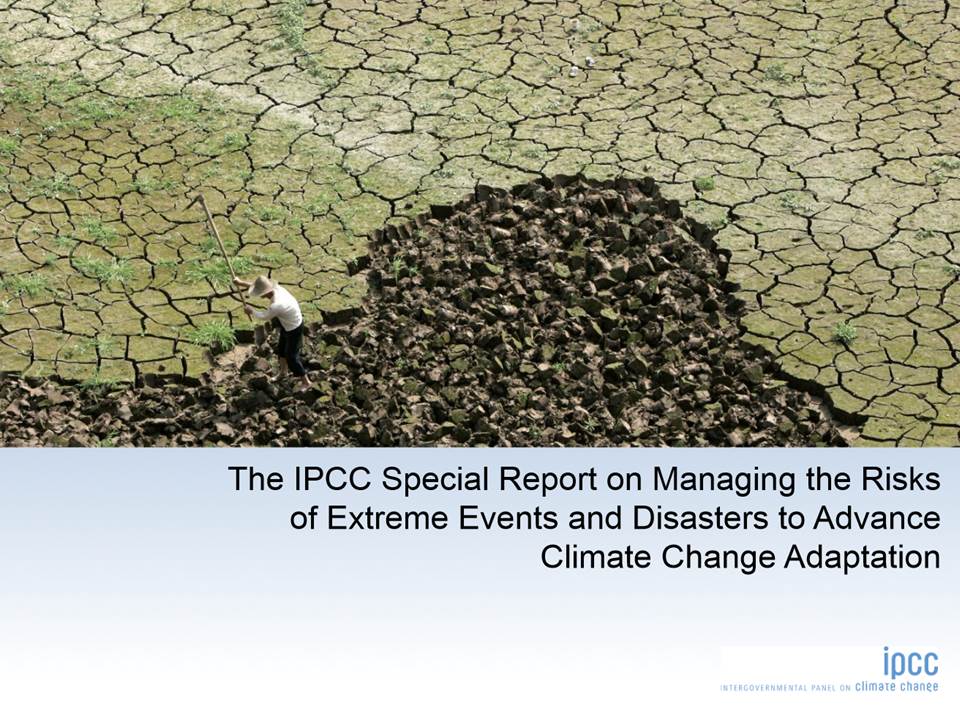di Francesco Scolaro
Il professore Jeffrey D. Sachs, direttore dell’Earth Institute della Columbia University, nella sua intervista pubblicata domenica 2 novembre 2014 su La Stampa, afferma: “Possiamo imboccare la via dello sviluppo sostenibile – la fine della povertà e la tutela dell’ambiente – o seguire un percorso di crescente disuguaglianza, sacche di povertà profonda e disastro ambientale. Questa è una scelta, non un destino. Il 2015 sarà un anno critico. Optiamo per lo sviluppo sostenibile.”
Le sue dichiarazioni sono arrivate nello stesso giorno nel quale è stato divulgato il quinto rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), presentato a Copenhagen tra il 27 e il 31 ottobre 2014. L’IPPC è una creatura delle Nazioni Unite che riunisce 195 Paesi e che ha iniziato a operare nel 1988 studiando – in chiave critica – il fenomeno dei cambiamenti climatici e i suoi potenziali impatti sull’ambiente e sulle società e le economie mondiali.
Il rapporto IPCC del 2014 fotografa una situazione che ha smesso di essere solo allarmante e che è diventata critica. Si individua un solo colpevole: l’azione dell’uomo. Dalla rivoluzione industriale in poi, l’essere umano non ha mai smesso di inquinare e con le emissioni di gas serra generate dal ciclo di produzione industriale, ha innescato una serie di cambiamenti che rischiano di diventare “gravi, diffusi e irreversibili”. Sintetizzando al massimo, il rapporto dice che se le emissioni di gas serra continuassero a crescere secondo l’attuale trend, l’aumento della temperatura al 2100 sarebbe di oltre 4 gradi. Per scongiurare il disastro globale, si deve contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi centigradi alla fine del secolo. Come si può fare? Si devono ridurre dal 40% al 70% le emissioni di gas nocivi tra il 2010 e il 2050, per puntare decisi alle emissioni zero nel 2100. Chi lo deve fare? Tutti i governi delle nazioni industrializzate devono muoversi come se fossero un unico individuo, mettendo da parte ogni rivendicazione in merito alle responsabilità della condizione attuale.
Nel 2014, le economie più inquinanti, che hanno il livello di carbon footprint più elevato, sono quelle della Cina e degli USA, seguiti con un grande distacco da India, Russia e Brasile. La Cina, da sola, produce più CO2 di USA e Europa messi insieme. Ma, ovviamente, se si facesse un computo sullo storico, i dati sarebbero diversi e aumenterebbero le responsabilità del Vecchio Continente. I Paesi emergenti (dalle citate Cina, India, Brasile, alla Corea del Sud, fino ai Paesi dell’Indocina e all’Indonesia) hanno opposto sin qui numerosi rifiuti alle proposte di rendere vincolanti a livello di ONU le quote di riduzione delle emissioni nocive in vista di una cooperazione verso obiettivi green, giustificando la loro scarsa sensibilità al tema con le esigenze di crescita economica. Ma, per il momento, anche Paesi con una maggiore anzianità di industrializzazione come gli USA non hanno fatto molto per ridurre le loro emissioni di gas serra, limitandosi a prendere solo generici impegni in tal senso.
Perché è proprio questo il principale fattore di inerzia: la ricerca del responsabile. L’Europa e i Paesi Occidentali vorrebbero coinvolgere anche i Paesi emergenti che adesso sono quelli più inquinanti, mentre questi rivendicano il loro diritto allo sviluppo economico e industriale, additando come i veri colpevoli dell’attuale livello di inquinamento globale le economie dei primi Stati che hanno adottato su larga scala il modello industriale. La caccia al colpevole, in casi come questi nei quali si sperimenta l’impatto dell’attività umana sull’ecosistema terrestre nel corso degli ultimi 250 anni, è tanto inutile quanto controproducente. Inutile, perché i rischi di un’eventuale mancata azione sono globali e colpiscono tutti, anche i non colpevoli o i meno colpevoli. Controproducente, perché rischia di creare alibi e di rafforzare le resistenze al cambiamento in un momento in cui non è più possibile restare fermi.
Dal 1° al 12 dicembre 2014, a Lima in Perù si riunisce la Conferenza delle Parti, organismo dell’ONU, per proseguire il confronto. Ma, secondo l’ONU, l’anno decisivo nella lotta al climate change sarà il 2015, anche alla luce della fitta serie di appuntamenti già in programma: dal 13 al 16 luglio, ad Addis Abeba in Etiopia, si terrà la Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo; a settembre la sessione dell’ONU varerà i nuovi Sustainable development goals che dal 2016 sostituiranno i Millennium development goals e dal 30 novembre all’11 dicembre la United Nations Climate Change Conference che si terrà a Parigi, da tutti ritenuto come il passaggio conclusivo nel quale si dovrebbe stringere l’accordo globale.
Non restano molte soluzioni e, nel corso del 2015, tutti i Paesi riuniti sotto l’egida dell’ONU dovranno cooperare per produrre il massimo sforzo al fine di salvare il Pianeta attraverso la progettazione e la successiva rapida attuazione di una strategia unitaria che riesca a mettere da parte vecchie e nuove “ragion di Stato”, le vecchie e nuove diffidenze e che sia in grado di guardare al futuro dell’umanità e della Terra con gli occhi dei figli dei nostri figli.
Tutte le soluzioni dovranno per forza di cose prevedere un sempre minore utilizzo dei combustibili fossili (dal petrolio, al carbone, passando per il gas), un attento e moderato impiego dei combustibili di nuova generazione (i cosiddetti biofuel, che sfruttano le biomasse ma che spesso implicano un eccessivo sfruttamento della terra a discapito delle colture dedicate all’alimentazione), un forte e massiccio investimento sulle energie pulite alternative (o a basso impatto) e sul variegato – e per il momento solo parzialmente esplorato – mondo dell’efficienza energetica, passando per l’educazione al risparmio energetico, per un più corretto ed equilibrato uso delle risorse idriche e delle derrate alimentari e per la lotta alla deforestazione e al land grabbing. La nuova Commissione europea potrebbe giocare d’anticipo, alzando l’asticella del dibattito interno, valutando il segnale che verrebbe dato ai mercati – in una fase economicamente instabile come quella attuale – con l’introduzione di un pacchetto di misure incentrato su una carbon tax applicata alle modalità di produzione dei beni di consumo: ciò comporterebbe l’innalzamento del prezzo di quei beni il cui processo di fabbricazione ha comportato il rilascio in atmosfera di grandi quantità di CO2, in maniera tale da orientare le scelte dei consumatori verso i prodotti a minore impatto ambientale che diventerebbero più convenienti, non solo dal punto di vista economico. Così facendo, anche i Paesi più restii ad accettare un tetto delle emissioni nocive (come alcuni Paesi asiatici, in cui l’export rappresenta una grossa fetta del PIL) sarebbero “costretti” ad adeguarsi per poter competere con i prodotti “low carbon”.
Solo se saremo capaci di smettere di vivere, pensare, produrre e consumare sentendoci parte di una singola “storia nazionale” (nel caso dell’Europa, “continentale”) e se saremo in grado di condividere l’idea di essere parte di una “storia universale”, solo se prenderemo coscienza di essere tutti uniti in un comune destino di progresso e di evoluzione, allora riusciremo a consegnare il nostro Pianeta alle generazioni future in condizioni migliori di come ci è stato affidato.