Anche in Africa la jihad arruola le donne, che pur non esercitando ruoli di rilievo decidono di abbracciare l’ideologia salafita. Un nuovo libro, pubblicato da Start InSight e scritto dal giornalista Marco Cochi, approfondisce le motivazioni e le aspirazioni che spingono migliaia di giovani e talvolta giovanissime a compiere una scelta che trasformerà la loro esistenza.
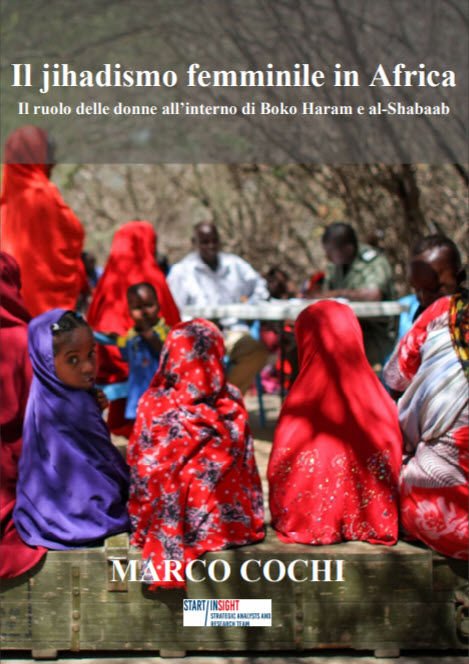
Nel suo nuovo volume (scaricabile gratuitamente a questo link), Cochi, già autore di due saggi sull’evoluzione della minaccia del terrorismo islamista in Africa e analista per l’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo (ReaCT) e per il think tank di geopolitica trentino “Il Nodo di Gordio”, parte dal presupposto che per comprendere meglio i processi di radicalizzazione è necessario fare il punto sul pregiudizio di genere tra le donne che abbracciano il jihadismo.
Per introdurre l’argomento, l’autore parte da lontano ricordando il ruolo chiave che nel XIX secolo alcune donne hanno avuto nelle organizzazioni estremiste violente. Tra tutte, la rivoluzionaria anarchica russa Vera Ivanovna Zasulich, la prima donna processata per terrorismo, che il 24 gennaio 1878 attentò alla vita del tirannico governatore di San Pietroburgo, il generale Fëdor Fëdorovic Trepov. Da allora, l’autore spiega che “la partecipazione delle donne al terrorismo può essere considerata una progressione naturale rispetto al loro coinvolgimento nelle lotte radicali e rivoluzionarie del passato”.
Nella sua disamina, Cochi spiega come le donne africane non siano direttamente impegnate sul campo di battaglia, pur svolgendo ruoli determinanti per il supporto del gruppo, come quello di spia, staffetta e addetta al reclutamento, oppure vengono impiegate in mansioni più pratiche come cuoca o lavandaia. Mentre i leader dei gruppi estremisti africani hanno spesso sottolineato nei loro comunicati l’importanza del ruolo delle donne come mogli e madri, determinanti per crescere i bambini secondo i dettami dell’islam radicale. Senza contare che le donne svolgono un ruolo di rilievo nella propagazione e diffusione dell’ideologia convincendo altre donne ad entrare a far parte del gruppo.
Ci sono anche alcune militanti all’interno del gruppo somalo al-Shabaab, che hanno svolto un ruolo attivo nella logistica e nell’esecuzione di attentati. Una tra tutte la convertita britannica Samantha Louise Lewthwaite, conosciuta anche come la “vedova bianca” per aver sposato Abdullah Shaheed Jamal, nome di guerra di Germaine Maurice Lindsay, uno dei quattro shahid di al-Qaeda che il 7 luglio 2005 seminarono morte e terrore a Londra. Dopo la scomparsa del marito, Samantha ha riempito le cronache dei giornali inglesi che la descrivono come la terrorista più ricercata del mondo, tanto da diventare una dei protagonisti di “World’s Most Wanted”, la docu-serie andata in onda la scorsa estate su Netflix. Un’esistenza votata al jihad segnata da quattro figli, tre mariti terroristi e un’interminabile latitanza, che il libro ripercorre con dovizia di particolari.
Il testo mette inoltre in rilievo anche il fatto che diventare estremiste può essere considerata una forma di emancipazione, che rende alle donne più facile staccarsi dalle famiglie d’origine, che in Africa sono in gran parte strutturate sull’autorità patriarcale. Ma questa, purtroppo, si rileverà un’amara illusione, come testimoniano i racconti delle giovani che sono riuscite a fuggire o sono state liberate dal giogo degli estremisti islamici. Racconti che descrivono molteplici stupri e trattamenti brutali da parte dei jihadisti.
Storie drammatiche intrise di dolore, sofferenza, ripetuti abusi sessuali di gruppo e di continui maltrattamenti, mentre molte delle reduci hanno raccontato di essere state ripetutamente costrette a fare uso di droghe, come il khat e il bugizi. Una cruda realtà per chi ha creduto che entrare a far parte di un gruppo jihadista rappresentasse una forma di riscatto sociale e liberazione.






















