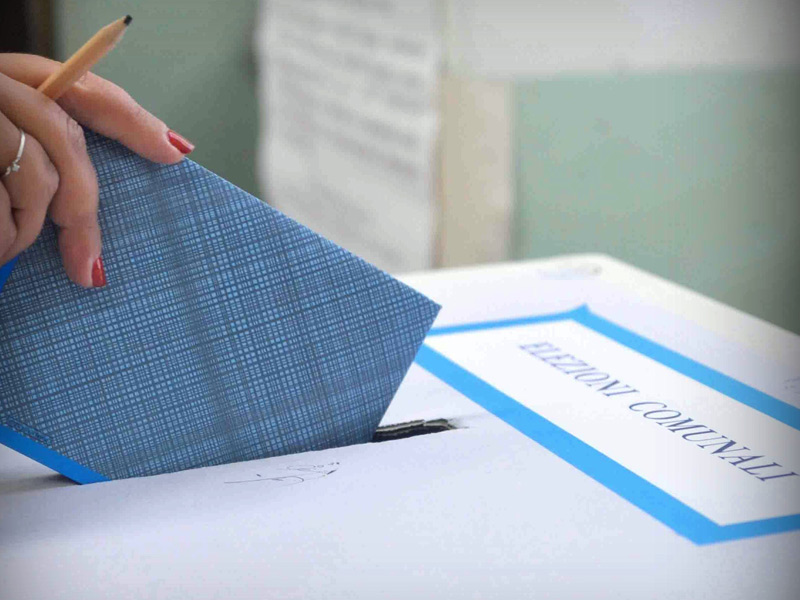Tra circa due mesi i cittadini decideranno sulla riduzione di deputati e senatori. L’art. 138 della Costituzione argine per la tutela delle libertà fondamentali dei cittadini. La lungimiranza dei padri costituenti e il “costo” della democrazia
Mentre in Emilia Romagna e in Calabria i rispettivi vincitori delle elezioni regionali erano intenti a festeggiare, il Consiglio dei Ministri fissava già una nuova data per le prossime votazione.
Niente paura, non è caduto il Governo, è solo stata indicato il giorno in cui gli italiani saranno chiamati a rispondere al quesito referendario sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari.
Detta così sembrerebbe una cosa di poco conto, sia dal punto di vista politico che giuridico. In realtà è esattamente il contrario.
Il 29 marzo 2020 (questa la data fissata per il referendum) è una data molto importante politicamente perché mette in evidenza la volontà dell’esecutivo di accelerare i tempi rispetto al taglio dei parlamentari tanto voluto dal Movimento 5 stelle. Infatti, dato che la vittoria dei sì è altamente probabile, l’entrata in vigore della legge chiude la possibile finestra per tornare a votare con le regole attuali che prevedono l’elezione di 945 parlamentari.
Per dirla in modo ancora più semplice e schietto, o il Governo cade prima del 29 marzo o alle prossime elezioni il Parlamento sarà composto da 600 tra Deputati (400) e Senatori (200). Ergo, la legislatura andrà avanti fino alla fine.
Dal punto di vista giuridico e storico, invece, stiamo parlando di una norma, quella contenuta appunto nell’articolo 138 della Costituzione e che prevede il referendum, davvero molto significativa e importante.
Il sistema descritto dall’articolo 138 ha infatti lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico. I membri dell’Assemblea costituente avevano vissuto l’esperienza del regime fascista ed avevano assistito allo svuotamento delle norme dello Statuto Albertino, poste a tutela delle libertà fondamentali dei cittadini, e alla loro sostituzione con le leggi ordinarie autoritarie ed antidemocratiche. Il timore che si potesse ripetere una simile esperienza spinse i Costituenti ad adottare un diverso tipo di Costituzione, non più flessibile, come era lo Statuto Albertino, ma rigida. Così si affermò la supremazia della Costituzione su tutte le altre leggi e si sancì la sua immodificabilità con le leggi ordinarie del Parlamento.
I “padri costituenti” sapevano però anche che la Costituzione non poteva essere immodificabile. Dovevano prevedere quindi che negli anni potevano rivelarsi necessari dei cambiamenti.
Ed è da questa consapevole e lungimirante consapevolezza che scaturì il complesso procedimento di revisione descritto dalla norma contenuta nell’articolo 138.
Ci sono quindi numerose garanzie, come le doppie votazione del Parlamento, la necessità della maggioranza assoluta, che richiede anche l’appoggio delle opposizioni, ed, appunto, il referendum popolare , ma anche una minima flessibilità.
Tradotto dal “giuridichese”: possono esserci necessità di cambiamento della Costituzione, ma avverranno solo se saranno coerenti con l’ordinamento democratico.
In realtà poche volte si è fatto ricorso a queste modifiche, anche perché, come sanno coloro che hanno studiato un minimo di diritto, esiste una Costituzione formale (scritta cioè) e una Costituzione materiale (cioè sostanziale, declinata secondo le evoluzioni del contesto storico, giuridico e sociale del Paese).
Parlando di referendum non abrogativi c’è però anche da ricordare che la nostra Carta li distingue tra istituzionali (solo quello del 2 giugno 1946 tra monarchia e Repubblica), di indirizzo (solo quello sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo del 18 giugno 1989) e costituzionali.
Quello sul taglio dei parlamentari sarà il quarto referendum costituzionale della storia, dopo quelli sul Titolo V della Costituzione del 2001 (il 7 ottobre per la precisione), sulla cosiddetta Devolution voluta dalla Lega al tempo guidata da Umberto Bossi (25 e 26 giugno 2006) e sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi del 4 dicembre 2016.
I precedenti dicono che il primo di questi referendum passò con il 64,2% di voti favorevoli seppur con una bassissima affluenza (poco oltre il 34%). Il 25-26 giugno 2006 gli italiani vennero invece chiamati a votare sulla riforma costituzionale varata dal governo Berlusconi e che fu bocciata dal 61% di coloro che si recarono alle urne (il 52% degli aventi diritti per la precisione).
Poi, fu la volta del referendum lanciato da Matteo Renzi e Maria Elena Boschi e che puntava al superamento del bicameralismo perfetto, alla revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, all’eliminazione dal testo costituzionale del riferimento alle Province e alla soppressione del Cnel.
Referendum sentito dagli Italiani (affluenza al 69%), ma non condiviso dal 59,11% dei votanti: Matteo Renzi fu così costretto a dimettersi da Presidente del Consiglio, come lui stessa aveva promesso in caso di sconfitta.
Questa volta, invece, l’esito del referendum non preoccupa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha commentato dichiarando di essere «fiducioso che ci sia un ampio schieramento dei cittadini a favore di questa riforma». Del resto l’esito positivo del referendum sarebbe per Conte la quasi certezza di portare a termine la legislatura e, quindi, di proseguire il proprio mandato, mentre un (improbabile) esito negativo potrebbe riaccendere la “voglia di voto” di Salvini e Meloni.
In attesa del 29 marzo, una certezza per tutti però c’è: indipendentemente dall’esito del referendum, 300 milioni di euro saranno comunque ugualmente spesi.