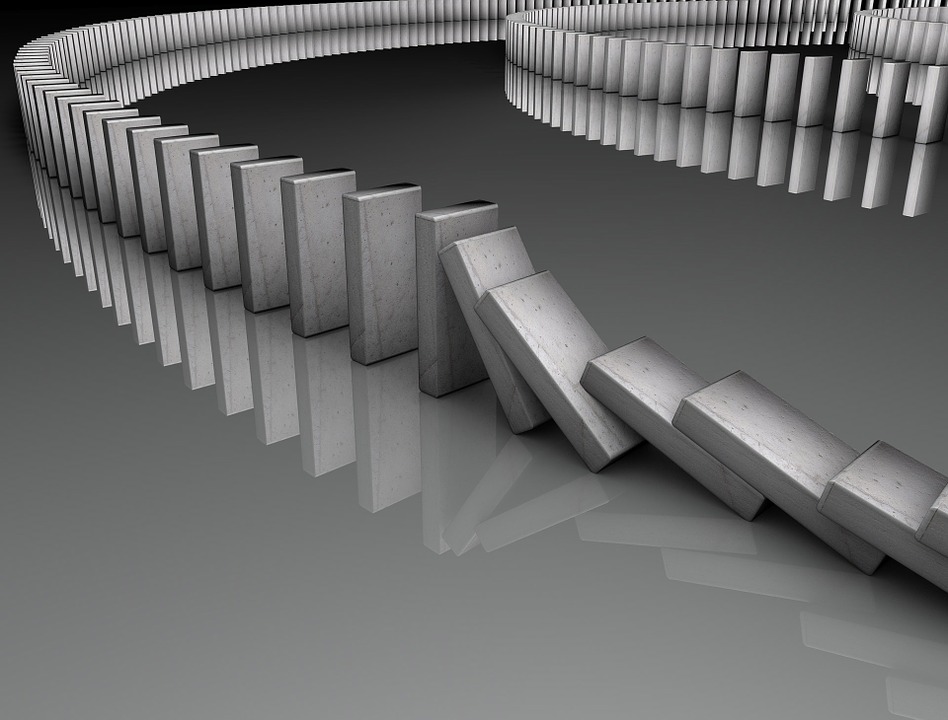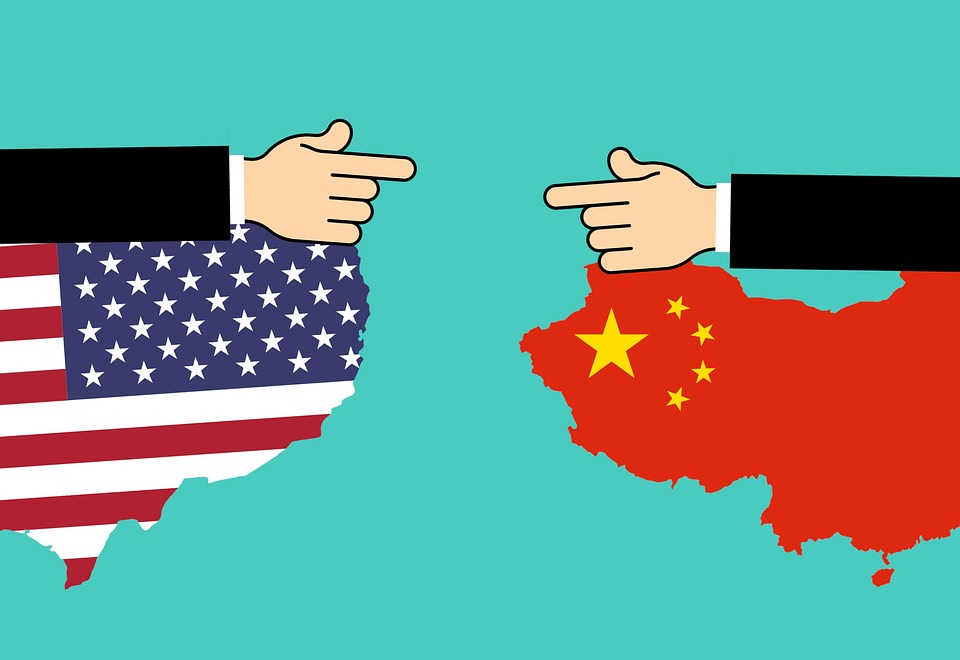Dall’era pre-fascista a quella che si avvicina alle prossime europee del 2019, passando per quella che disse sì (votando no) al divorzio, sancendo la fine della leadership di Fanfani: in una società che ormai consuma in fretta, compulsivamente (e non ha grandi preclusioni, né robuste barriere invalicabili di natura ideologica) i partiti sono chiamati continuamente ad una sfida per la sopravvivenza. L’analisi di Luca Tentoni
di Luca Tentoni
Talvolta, per prefigurare scenari politici, si fa ricorso ad un passato anche remoto. Nel Novecento le subculture politiche territoriali hanno lasciato una profonda impronta nella società, tanto da riemergere carsicamente – soprattutto nel caso di quella socialcomunista – dopo il ventennio fascista.
Eppure, se si vanno a guardare le stime sulla composizione dell’elettorato della provincia di Vicenza nel 1946 (elezioni per la Costituente, referendum istituzionale), rapportata con quello del 1921 (elezioni politiche) elaborate a suo tempo da Allum, Feltrin e Salin (“Le votazioni del 1946 a Vicenza”, in “Il triplice voto del 1946”, ed. Liguori, 1989) si nota che su cento aventi diritto al voto alle prime elezioni libere dopo il fascismo solo 22 erano elettori anche venticinque anni prima.
Nel frattempo, la cancellazione (per morte o emigrazione) della metà degli elettori 1921, unita all’afflusso di chi nel frattempo aveva maturato i requisiti per votare (neoiscritti, immigrati, giovani, pari a circa il 25%) e naturalmente l’aggiunta delle donne (ammesse a votare per la prima volta proprio nel ’46 e rappresentanti il 53% del corpo elettorale) aveva drasticamente mutato il quadro. Eppure, con solo un quarto o poco più degli elettori del 1946 “ereditato” dal 1921, le tendenze politiche non mutavano. Resistevano, nonostante quella fascista non fosse stata una semplice “parentesi”.
Così, quel 49,9% ottenuto dal PPI di Don Sturzo nel 1921 nel vicentino diventava il 61-62% del voto Dc alle amministrative (elezioni provinciali) e alla Costituente nel 1946; dal canto suo, il 24,7% ottenuto da socialisti e comunisti nel 1921 si trasformava nel 32,2% delle politiche, confermando il rapporto di forza (due a uno per i democristiani) e il “colore” (bianco) dell’insediamento.
È solo un caso, ma come si legge anche in altri studi, come quello di Marco Almagisti (“Una democrazia possibile”, ed. Carocci, 2016) e, molto tempo prima, nel prezioso e rarissimo libro di Ugo Giusti (“Dai plebisciti alla Costituente”, ed. Faro, 1945) per non parlare degli studi di Francesco Compagna e Vittorio De Caprariis negli anni Cinquanta e quelli di Pier Luigi Ballini, Maurizio Ridolfi e Rosario Forlenza in tempi più recenti, ci sono discontinuità da non trascurare ma anche continuità subculturali fortissime, in particolare in alcune aree del Paese (le regioni “rosse” o quelle “bianche”).
Ci sono, o meglio c’erano. Fra il 1919-1921 e il 1946, ma persino – c’è chi le ha notate ed evidenziate, mostrando dati eccezionalmente simili, resistenti al logorio del tempo – fra il 1946 (referendum e Costituente) e il 1974 (referendum sul divorzio) e il 1975-1976 (amministrative e politiche). Se i residui della subcultura “bianca” sono stati meno forti e duraturi di quelli della subcultura “rossa”, fino al 2008 abbiamo osservato persistenze in alcune province del Paese. Mutazioni nel segno di una qualche continuità, come nel passaggio dalla Dc (e non solo, anche dal Psi) alla Lega nel Nord-Est e in parte della Lombardia, ma soprattutto la consistenza degli eredi del Pci nel Centronord “rosso”.
Oggi che questa mappa dell’Italia multicolore (come la definì Ilvo Diamanti) va mutando e alcune tendenze si affievoliscono, sotto i colpi di una volatilità elettorale giunta a livelli record fra il 2013 e il 2018 (senza contare le regionali degli ultimi sei anni), nulla è più scontato.
A Roma, i quartieri dove prevaleva il Pci non sono andati al Pd, il quale, per contro, ha conquistato posizioni che (in zone centrali) erano un tempo appannaggio della Dc e dei partiti moderati (liberali, monarchici) e, più di recente, della CdL.
Nell’immediato futuro – le elezioni europee del 26 maggio – e nei prossimi tre-cinque anni, a quante mutazioni assisteremo ancora, adesso che i “filoni politici carsici” (le grandi ideologie, le appartenenze) non sembrano sussistere neppure nei residui bastioni di quella che fu per quasi un secolo la “repubblica rossa” fra Toscana, Emilia, Umbria e parte settentrionale delle Marche? Oggi è più difficile rifarsi ai precedenti, anche se una certa “memoria politica territoriale” non è del tutto scomparsa. Tuttavia, non è più possibile disegnare o solo ipotizzare scenari di medio periodo.
Nel 2009 il PdL era all’apice del successo; nel 2014 toccò al Pd, giunto oltre il 40%. Ci sarà dunque da chiedersi, una volta letti i risultati del 2019, cosa ne resterà negli anni a venire. In una società che ormai consuma in fretta, compulsivamente (e non ha grandi preclusioni, né robuste barriere invalicabili di natura ideologica) i partiti sono chiamati continuamente ad una sfida per la sopravvivenza.
Guardare al consenso e contemporaneamente alla propria definizione o ridefinizione di ruolo al governo o all’opposizione è un esercizio difficile, forse arduo per classi dirigenti chiamate ad uno sforzo superiore rispetto a quello di chi – in passato – poteva almeno contare sulle roccaforti e su una quota di “fedelissimi” impermeabile rispetto a tutte le intemperie politiche, economiche e sociali.